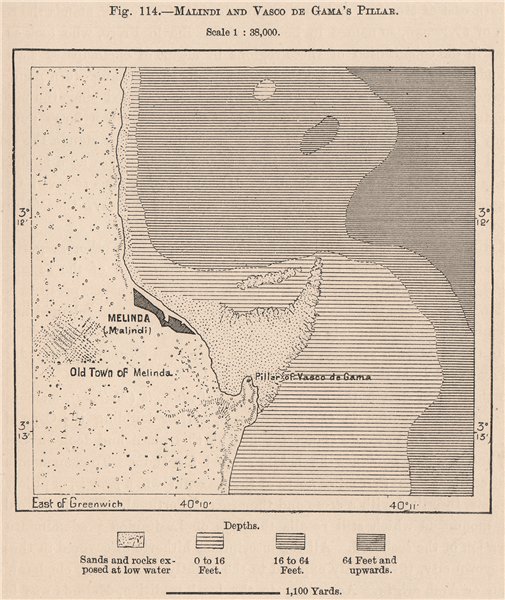di Anna Bono

Per qualcuno, e forse per molti, Kuki Gallmann è un personaggio di fantasia, la protagonista di un bel film del 2002, Sognando l’Africa, interpretato dall’attrice Kim Basinger. Ma Kuki invece esiste, è una persona reale. È italiana, nata a Treviso, e vive in Africa da 50 anni, da quando cioè nel 1972, all’età di 29 anni, si è trasferita con il marito Paolo e con il figlio, il piccolo Emanuele nato da un precedente matrimonio, in una tenuta di 100.000 acri acquistata in Kenya: il Ranch Ol ari Nyiro, situato a nord della capitale Nairobi, sul bordo orientale della Rift Valley.
È li che Kuki abita anche adesso, insieme alla figlia Sveva. Paolo ed Emanuele invece non ci sono più. Paolo è morto nel 1980. Era andato sulla costa a ritirare una culla di legno intagliato commissionata a un artigiano locale per Sveva che stava per nascere. È deceduto in un incidente d’auto sulla strada Mombasa-Nairobi. Tre anni dopo è morto anche Emanuele, che aveva solo 17 anni, ucciso dal morso di un serpente velenoso. Nel loro ricordo Kuki ha istituito l’organizzazione no profit Gallmann Memorial Foundation.

Kuki e Sveva hanno fatto di Ol ari Nyiro una riserva faunistica, la Mukutan Conservancy, dove vivono centinaia di elefanti, bufali, zebre, antilopi e gazzelle; e ancora, ghepardi, leopardi e leoni – i grandi predatori della savana – e innumerevoli varietà di uccelli. La riserva è aperta ai visitatori ai quali si offrono le emozioni dei game safari su jeep e a piedi. Per ospitarli è stato costruito il Mukutan Retreat, un lodge realizzato fondendo stile coloniale, a sua volta sintesi di culture – inglese, indiana, araba, swahili… – e soluzioni architettoniche pensate per integrare gli edifici nella natura e limitarne l’impatto ambientale. I cottage sono modellati nella roccia e arredati con mobili e oggetti da tutto il mondo in una sintesi squisita.
“Questa è l’Africa, e la più selvaggia, indisturbata e imprevedibile – si legge nelle brochure che descrivono la riserva – ogni desiderio è curato nei minimi dettagli, il Mukutan Retreat fa sentire i propri ospiti come se fossero su un mondo a parte, indimenticabile, un tempio della natura”.
Ma quello che non tutti i visitatori sanno quando lasciano la riserva, forse già come Ernest Hemingway pervasi di nostalgia d’Africa e desiderio di ritornare, è che la Mukutan Conservancy, questo tempio della natura al quale Kuki e Sveva Gallmann hanno dedicato tutta la vita, per esistere ha bisogno di essere difesa da un esercito di ranger armati.

In Kenya, come in gran parte dell’Africa, la fauna selvatica, un patrimonio dell’umanità, è sotto costante, duplice minaccia: di essere decimata dai bracconieri, che riforniscono di zanne, corni di rinoceronte, pelli di pangolino gli insaziabili mercati asiatici, e di essere privata dell’habitat dai pastori transumanti, che invadono parchi e riserve con le loro mandrie.
Da sempre gli africani integrano con la caccia le loro tradizionali economie di sussistenza. Ma a uccidere gli animali selvatici a milioni adesso sono i bracconieri che agiscono in bande, dotati di fuoristrada, armi sofisticate, sistemi satellitari per individuare gli animali, persino di fucili con silenziatori e costosissimi visori notturni infrarosso di terza generazione, e sono collegati alle reti internazionali del contrabbando di prodotti della fauna selvatica, un commercio illegale che può fruttare anche 23 miliardi di dollari in un anno. Al chilogrammo i corni di rinoceronte valgono più di 90.000 dollari, le zanne di elefante da 1.000 a 1.500 dollari. L’incuria, la connivenza e, troppo spesso, la complicità di funzionari, politici, militari consentono ai bracconieri di agire su vasta scala. Attratti dai profitti elevati, anche alcuni dei gruppi jihadisti che infestano il continente sono entrati nel traffico. Gli al Shabaab somali affiliati ad al Qaeda, ad esempio, ricavano dal contrabbando dell’avorio, frutto del bracconaggio in Kenya, fino al 40 per cento dei fondi con cui si finanziano. L’agenzia di informazione Maisha consulting per questo ha coniato uno slogan: “il jihad africano: prima massacra animali innocenti e poi fa strage di persone innocenti”.
I pastori e il loro bestiame rappresentano l’altra minaccia: non solo alla fauna selvatica, ma anche ad alcuni degli ecosistemi africani più fragili e alla biodiversità, oltre che alla sicurezza delle comunità contadine con cui entrano in competizione per il controllo di terre fertili e punti d’acqua. Quello tra tribù di pastori e di agricoltori è uno conflitto plurisecolare, dalle sorti alterne. In passato spesso è stato vinto dagli agricoltori, più forti per numero e risorse. Poi qualcosa è cambiato. In tutta la fascia sub-sahariana i pastori, che appartengano alla grande famiglia etnica dei Fulani-Peul dell’Africa occidentale e centrale o alle tribù nilotiche – Samburu, Maasai, Pokot… – che popolano le savane dell’Africa orientale, hanno sostituito lancia, arco e frecce con gli AK47 e con altre armi moderne. Per i pastori africani il bestiame è anche un fondamentale simbolo di status. Per questo cercano di moltiplicare il numero di capi in loro possesso, anche oltre il limite della sostenibilità ambientale. Le armi servono a rubare capi di bestiame, attaccare e incendiare villaggi di contadini costringendo gli abitanti a trasferirsi altrove e assicurarsi nuovi e più vasti territori in cui far pascolare le mandrie. In Kenya difficilmente riescono a sconfinare nelle regioni ben coltivate dalle etnie dominanti Kikuyu e Kamba e allora entrano con le mandrie nelle riserve faunistiche. Pur sapendo il danno che infliggono al paese, in cui il turismo è una delle principali voci di bilancio, dei leader politici li istigano a farlo, gridando all’ingiustizia, per ottenere consenso politico e voti.

Per i bracconieri la Mukutan Conservancy è una ricca concentrazione di animali selvatici a cui attingere, se solo non fosse così ben custodita da ranger armati. Per i pastori è una quantità di acqua e pascoli a portata di mano, ma inaccessibili, di cui non vedono l’ora di appropriarsi. Gli uni e gli altri vogliono liberarsi di Kuki Gallmann e della Mukutan Conservancy, disposti a tutto, anche a uccidere.
Hanno provato più volte a minacciare Kuki per indurla ad andarsene. Nel 2017 ci sono quasi riusciti. La mattina del 23 aprile 2017 Kuki è stata vittima di un agguato. Giorni prima, decine di uomini armati avevano attaccato la sua proprietà ed erano riusciti a incendiare uno dei cottage del lodge. Solo per miracolo i proiettili non avevano colpito la figlia Sveva accorsa sentendo grida e spari. Quella mattina, accompagnata dal personale del Kenya Wildlife Service e da alcuni suoi ranger, Kuki era andata a fare un sopralluogo dei danni subiti. Prudentemente, come di consueto, stavano tornando indietro per una pista diversa da quella percorsa all’andata. Ma a un certo punto hanno trovato la strada sbarrata da un albero caduto e sono stati costretti a fermarsi. Allora tre uomini sono sbucati dalla boscaglia e hanno aperto il fuoco. Kuki è stata ripetutamente colpita all’addome. Trasportata d’urgenza all’Aga Khan Hospital di Nairobi, è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. Per settimane si è temuto per la sua vita. Sono trascorsi mesi prima che potesse tornare a casa. L’attentato – non si è saputo se gli autori fossero bracconieri o pastori – l’ha spaventata, ma l’ha resa ancora più determinata a proteggere la sua riserva naturale.
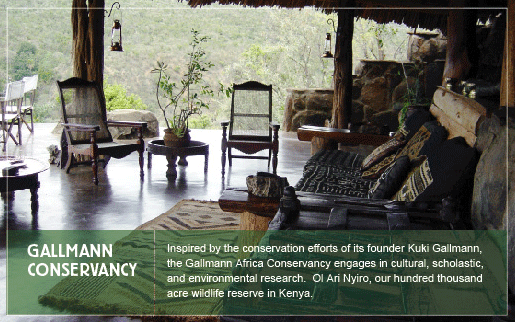
Quattro anni dopo, il 13 maggio 2021, Kuki era alla guida della sua auto quando di nuovo è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco sparati da un gruppo di pastori entrati di nascosto nella riserva. Ferita a una gamba, sotto il ginocchio, è stata ricoverata in un ospedale della capitale e sottoposta a un intervento chirurgico. Per delle serie complicazioni sopravvenute, ha potuto lasciare l’ospedale solo dopo tre mesi e ancora una volta è tornata a casa.
“Ha la grazia di una aristocratica italiana e la volontà inarrestabile di un branco di elefanti – ha scritto di lei la produttrice cinematografica Allyn Stewart – combatte per gli animali come fossero suoi figli, tratta e media con le tribù in conflitto come se fossero la sua famiglia e si prende cura della terra come se fosse lei stessa Madre natura. Lei e sua figlia Sveva hanno fatto della conservazione della natura e della fauna selvatica la loro missione”.
“I veri monumenti – dice Kuki – non sono più Firenze e Venezia. Tutto ciò che è fabbricato dall’uomo può essere in qualche misura rifatto. L’elefante, il rinoceronte, le foreste, le sorgenti naturali… una volta persi, sono persi per sempre”.